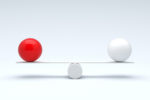Il concetto di libertà

Il concetto di libertà è strettamente connesso alla riflessione, propria di tutto l’ebraismo, sulla natura e sui doveri dell’uomo. L’uomo, in base al libero arbitrio che gli è dato, può scegliere il suo destino, che tuttavia non è indipendente dalla volontà del Signore. L’ebreo per questo è chiamato alla realizzazione di una spiritualità, oltre che al compimento di opere concrete. Tali opere sono per questo legate a riferimenti di valore, regole di comportamento, leggi fondate su principi etici. Il progetto di ogni uomo, ai fini della propria esistenza, va quindi fondato, nell’ebraismo, su uno stretto legame tra libertà e legge. Per l’ebraismo, quando si parla di legge, il riferimento è la Torah. Torah significa essenzialmente insegnamento e con essa ci si riferisce al Pentateuco e in senso più ampio a tutta la tradizione sacra. Il racconto biblico non va visto come una narrazione del passato ma come base di insegnamento per tutti gli aspetti della vita quotidiana. Per quanto riguarda la libertà, l’idea che deriva dai Testi è chiara: essa non ha senso se non nel rispetto di regole, e di una legge che fissi e orienti i rapporti tra uomo e uomo e tra uomo e Dio.
Il rapporto tra legge e libertà è definito con precisione nel racconto della Bibbia, in particolare nel libro dell’Esodo. La storia a tutti nota è quella di un popolo che viene strappato, forse anche contro la sua volontà, dalla schiavitù egiziana, e che poi, a 50 giorni dal giorno in cui è stato liberato, assiste alla rivelazione divina con la promulgazione del decalogo sul monte Sinai. Il modello dell’uscita dall’Egitto diventa fondamento dell’esperienza religiosa ebraica, base della legge, criterio di riferimento per un sistema di diritto dove non c’è posto per l’ingiustizia e l’oppressione[2].
La conquista della libertà, in questa storia remota ma sempre presente, non è stata agile né veloce, ha richiesto la crescita di un popolo che stentava a dimenticare le abitudini della passata condizione di schiavitù egiziana, ma ha infine garantito una presa di coscienza totale e determinante, ha favorito la consapevolezza dell’importanza di una legge da rispettare.
Il primo passo della storia ebraica è un atto di liberazione da un destino prefissato, una scelta volontaria e obbediente a un Dio. L’Esodo è una seconda nascita, da un’altra madrepatria, l’Egitto, dove Israele è rimasto in incubazione per 430 anni (…) divenendo moltitudine. Ora si tratta della dialettica tra schiavitù e liberazione. Michael Walzer ha dimostrato nel suo libro Esodo e rivoluzione come l’Esodo sia stato assunto come paradigma dai più importanti movimenti di emancipazione e in ogni rivoluzione fino al XX° Secolo, nell’area di cultura biblica e cioè in America e in Europa: è una metafora di guida, poetica o anche direttamente religiosa, in cui le masse oppresse si rispecchiano, riconoscono un loro Mosé che rivela di una verità prima nascosta e una direzione, verso nuovi cieli e nuove terre. Tuttavia la liberazione non è ancora libertà. (…) le generazioni che uscivano dall’Egitto avevano ancora le stimmate della schiavitù. Nelle incertezze della migrazione sentivano la nostalgia delle abitudini dell’Egitto, di ciò che era conosciuto, seppure nell’oppressione. Erano mature per la liberazione ma non ancora per la libertà. Le generazioni degli schiavi liberati si consumarono lungo i 40 anni nel deserto, e solo la successiva nata libera poté raggiungere la terra promessa. Ne deduciamo che la spontaneità non è immediatamente libertà: è spesso vincolata ad abitudini sedimentate, a coazioni a ripetere. I movimenti di liberazione, collettivi o interiori, si sottopongono per questo a una disciplina, rompono il giogo loro imposto per sottomettersi ad un altro giogo liberamente scelto. O nel senso che ritornano ad una schiavitù sotto altre forme (qual è il vitello d’oro che ripete l’Egitto), o al contrario perché è proprio una disciplina scelta a liberare da una disciplina imposta: tale è il dono della Torà sul Sinai[3].
Nella visione ebraica, il concetto di libertà nasce nella consapevolezza della sottomissione ai dettami divini, alla Torah: una volta conquistata la libertà, gli ebrei hanno riconosciuto nel Signore il loro unico padrone, e solo di lui possono considerarsi schiavi. La sottomissione totale al testo della Torah ha cioè come contropartita la libertà da qualsiasi altro tipo di subordinazione. Accettando la legge divina ci si assicura l’indipendenza da altri “padroni”.
Il concetto di libertà non va inteso nel senso negativo di assenza di costrizione, che creerebbe il caos al livello sociale. L’idea di libertà è invece intesa, secondo l’accezione positiva, come rispetto di quell’insieme di valori etici che vengono condivisi dalla collettività.
Da ciò il carattere ricorrente nelle festività, in particolare in quelle di Pesach e di Shavuòt, e nel rispetto del sabato, del tema della libertà e della redenzione.
Se Pesach è la libertà fisica, Shavuot rappresenta la libertà spirituale preceduta da 49 giorni di preparazione nei quali ogni ebreo, ogni anno, rivive l’esperienza dei padri (ma anche la propria) nell’approccio alla Legge. Qui sorge il paradosso dell’ebraismo. La libertà non può che venire dalla autosottomissione, volontaria, alla Legge Divina. La libertà del popolo di Israele è completa nel momento in cui Israele diventa schiavo di D-o. “Essi sono Miei schiavi”, e non schiavi degli schiavi. La libertà di essere schiavi di D-o dunque. Ma il concetto della libertà è ancora più chiaro se si pensa allo Shabbat. L’unico possibile riposo secondo la Torà è il dedicarsi completamente al culto Divino, innalzando tutto ciò che è materiale ad un livello sacrale (ad es. sesso, cibo, abbigliamento)[4].
Nel rapporto che si crea tra idea di libertà, norme religiose e leggi giuridiche dell’ordinamento statale, è importante sottolineare come naturalmente l’obbedienza ai dettami della Torah cammini di pari passo al rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato di vita e residenza.
“La legge dello Stato è legge”, è una frase fondamentale e antichissima del diritto ebraico, dove è costante la ricerca di una complementarietà tra la salvaguardia della tradizione e le norme che regolano lo Stato, la vita civile e la convivenza, che oggi definiamo civile e democratica[5].
Questa disposizione politica e i problemi inerenti hanno un’attualità evidente oggi, nelle società multietniche, multiculturali e multireligiose. Vi si delinea un campo di tensione tra legge interna ad una comunità (la Halakhà per gli ebrei) e le regole sociali e statuali in cui la comunità vive. La zona di interferenza tra regole e tradizioni comunitarie da un lato, e senso comune maggioritario e norme vigenti dall’altro, è luogo di contrattazione formale e informale: confronto di culture. (…) E’ una zona di turbolenza dove si confrontano i diritti e i doveri di cittadinanza dei singoli, e i vincoli di appartenenza collettivi a una comunità: è il confronto tra le libertà della persona e la libertà del gruppo[6].
Va precisato che il processo che lega la libertà e le regole di convivenza è in costante evoluzione anche nel confronto tra fedi e sensibilità.
Alcune religioni monoteistiche hanno faticato molto nel tentativo di conciliare i fondamenti della società attuale con l’idea di origine sacra degli ordinamenti dei propri sistemi; spesso il risultato è quello di un compromesso più o meno onorevole nel quale si cerca di far convivere le differenze separando gli ambiti di competenza. Altre religioni non hanno neppure fatto questo tentativo, o sono giunte, in alcune loro componenti, alla conclusione di opporsi totalmente al sistema democratico. E siamo così arrivati alla dolorosa recente constatazione che in questo mondo globalizzato l’estremismo religioso, opposto ai valori centrali della democrazia, è diventato veramente una minaccia seria[7].
Da ciò parte e si sviluppa l’analisi sulla libertà che per gli ebrei, come accennato, ha nella ricorrenza di Pesach un momento centrale di analisi e di condivisione.
[2] Riccardo Di Segni, http://www.morasha.it/zehut/rds18_liberta.html
[3] Stefano Levi Dalla Torre, https://docplayer.it/11118522-Liberta-dell-uomo-ed-esperienza-religiosa-nella-tradizione-ebraica.html
[4] Jonathan Pacifici, http://www.archivio-torah.it/jonathan/3058.pdf.
[5] Si veda l’unità sulla società civile, paragrafo “Ebrei e stato di diritto”.
[6] Stefano Levi Dalla Torre, Zone di turbolenza, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 214
[7] Riccardo Di Segni, http://www.morasha.it/zehut/rds18_liberta.html